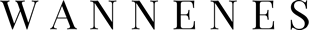120
GIOVANNI BATTISTA PIRANESI
GIOVANNI BATTISTA PIRANESI
(Mogliano Veneto, 1720 - Roma, 1778)
Veduta della piazza di Montecavallo
Acquaforte su carta, mm 390X550
Bibliografia:
La Roma di Piranesi. La città del Settecento nelle grandi Vedute, catalogo della mostra a cura di Mario Bevilacqua e Mario Gori Sassoli, Roma 2006, p. 139, con bibliografia precedente.
Questa veduta della piazza è concepita dal Piranesi secondo una prospettiva immaginaria. Al centro si erge l'obelisco e il gruppo marmoreo dei Dioscuri Castore e Polluce con i loro cavalli rampanti. Da queste sculture, copie romane da originali ellenici, deriva l'antica denominazione di Piazza Monte Cavallo.
Veduta della piazza di Montecavallo
Acquaforte su carta, mm 390X550
Bibliografia:
La Roma di Piranesi. La città del Settecento nelle grandi Vedute, catalogo della mostra a cura di Mario Bevilacqua e Mario Gori Sassoli, Roma 2006, p. 139, con bibliografia precedente.
Questa veduta della piazza è concepita dal Piranesi secondo una prospettiva immaginaria. Al centro si erge l'obelisco e il gruppo marmoreo dei Dioscuri Castore e Polluce con i loro cavalli rampanti. Da queste sculture, copie romane da originali ellenici, deriva l'antica denominazione di Piazza Monte Cavallo.
ESTIMATE € 1.500 - 1.800